Come raccontare il cambiamento climatico?
Se ne è discusso il 14 Febbraio a Milano durante uno stimolante workshop presso l’Università Bicocca

Cosa c’entrano, potreste chiedervi, un’antropologa, una linguista e una neuroscienziata con il cambiamento del clima ed il riscaldamento del pianeta? Le tre ricercatrici, insieme a una climatologa e una studiosa di idrologia, potrebbero apparire male assortite, ma non è ciò che è sembrato al pubblico che ha partecipato al bell’incontro tenutosi lo scorso 14 Febbraio a Milano, presso il dipartimento di scienze ambientali e della Terra dell’Università Bicocca di Milano.
Il problema di come comunicare e raccontare il cambiamento climatico non è nuovo nella comunità scientifica e diventa sempre più pressante vista la lentezza esasperante con cui la società e il sistema economico stanno rispondendo alla crisi. Gli scienziati, lo sappiamo, sono molto bravi a produrre calcoli, dati, modelli e grafici; alcuni di loro sono anche abili divulgatori, ma per quanto riguarda il clima (come per tutto il discorso sulla salvaguardia dell’ambiente) bisogna purtroppo prendere atto che il loro messaggio non ha fatto breccia nella società e che l’urgenza di un’azione adeguata è percepita soltanto da una minoranza nella popolazione e nella classe dirigente (si pensi alla scarsa efficacia delle annuali conferenze internazionali chiamate COP, il cui numero è arrivato a 27).
Di cosa abbiamo bisogno per fare un salto di qualità nel livello della comunicazione? Quali sono gli errori da evitare e quale linguaggio risulta più appropriato per toccare le corde delle persone? Le relatrici (in un evento tutto al femminile) hanno provato a spiegarlo a una platea numerosa e attenta attraverso le loro presentazioni, il cui unico limite è stato la ristrettezza del tempo a disposizione.

La conferenza è stata aperta dalla professoressa Elisa Palazzi, climatologa, che ha affrontato il problema della comunicazione dell’incertezza nei futuri scenari climatici. Si tratta di un argomento molto familiare agli studiosi dell’atmosfera e agli stessi meteorologi (che lo affrontano nel lavoro quotidiano: ne abbiamo parlato in questo articolo). Le sorgenti dell’incertezza derivano sia dai modelli climatici, sia dagli scenari socioeconomici; è fondamentale conoscere e quantificare le incertezze per non nascondere i rischi e per accrescere le probabilità di un corretto adattamento al nuovo clima.
La dottoressa Carla Sciarra, ingegnera, nella sua presentazione ha esordito sottolineando la necessità di un approccio interdisciplinare (non a caso ha condiviso il suo tempo con la dottoressa Irene Ronga, neuroscienziata). Nel seguito ha mostrato l’importanza di confezionare un messaggio efficace prendendo esempi dal suo ambito di ricerca, l’idrologia. Una buona comunicazione deve essere accompagnata da immagini che spieghino in modo semplice i dati, che si tratti, ad esempio, della contrazione del lago Aral o dell’impronta idrica della produzione del cibo.
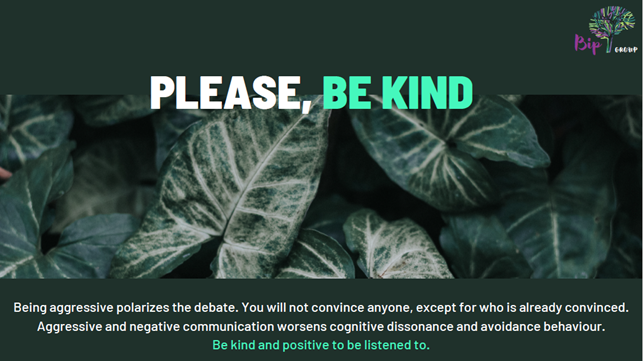
Con la presentazione di Irene Ronga, neuroscienziata, ci siamo avvicinati al mondo della psicologia cognitiva: la comunicazione del cambiamento climatico infatti deve fare i conti con le caratteristiche del cervello umano e con alcuni dei suoi limiti, in particolare la dissonanza cognitiva e i pregiudizi cognitivi (cognitive biases).
La mitigazione della crisi climatica ci chiede di modificare alcuni comportamenti e non potrebbe esserci paragone migliore che l’impegno di mettersi a dieta. Davanti a un medico che ci ha prescritto un triste regime alimentare il nostro cervello tende ad andare alla ricerca di scorciatoie, o addirittura proverà a rimuovere il problema con delle scuse: “il medico si sbaglia”, “la mia dieta è ricca di verdure, quindi non serve modificarla”, “un anno è tanto tempo, inizierò la settimana prossima”. Suona familiare? Sono scuse molto simili a quelle che accampiamo per rimandare le azioni in difesa del clima. Di fronte a queste resistenze la neuroscienziata suggerisce di non essere aggressivi con l’interlocutore, di controllare scrupolosamente la qualità e l’origine dei dati che stiamo usando nel messaggio, di accompagnare la descrizione del problema con quello della sua soluzione e di sottolineare le opportunità.
Maria Cristina Caimotto, la quarta relatrice, ha introdotto il pubblico in un campo di ricerca sicuramente nuovo per molti dei partecipanti. Quanti hanno mai udito il termine ecolinguistica? Partendo dal presupposto che i sistemi economici (responsabili della distruzione ambientale) sono strutturati attraverso il linguaggio, l’ecolinguistica si pone l’obiettivo di criticare le forme del linguaggio che contribuiscono al danno ecologico e di ricercarne di nuove. Si tratta, in altre parole, di smontare i paradigmi (idee condivise) negativi che tengono assieme le società per aprirsi a idee nuove. Per consegnare un messaggio positivo (ad esempio nell’ambito del clima) l’esperta suggerisce di ricorrere a metafore per ridurre la complessità, ma stando attenti ai paragoni che si utilizzano (meglio paragonare l’effetto serra a una coperta o ad un forno? La coperta nell’immaginario comune evoca qualcosa di positivo). Nel seguito sono stati molti gli spunti stimolanti della presentazione della professoressa Caimotto, tutti attinenti l’uso del linguaggio: la critica al termine “sviluppo sostenibile” e al “Crescitismo” (la crescita è percepita a prescindere come buona e il nostro linguaggio tende a rifiutare la presenza dei limiti e degli agenti non umani); il concetto di “environmental framing”, cioè la necessità di costruire una struttura linguistica nuova che rifugga dall’uso del linguaggio mutuato dal gergo dei mercati (con riferimento al saggio di Mautner, “The marketisation of language”); nel solco di questa critica segue l’esortazione a liberarsi dagli “inglesismi tossici”, cioè del “Bad Simple English” in quanto lingua del marketing globale. A un livello più pratico, infine, la presentazione ha fornito utili suggerimenti su come strutturare un messaggio o sostenere un dibattito nell’ambito del “reframing”: il discorso dovrà imperniarsi sui valori, non dovrà usare la cornice linguistica dell’avversario, farà ricorso a termini semplici, sarà arricchito da immagini, dovrà raccontare storie in grado di muovere emozioni.

Dopo una serie di discorsi tanto impegnativi l’ultima serie di slide ci ha trasportati per qualche minuto nell’atmosfera rilassata delle isole dell’Oceano Pacifico. Il compito è stato affidato alla dottoressa Emanuela Borgnino, antropologa, che ha studiato le culture degli indigeni di queste remote (almeno per noi) regioni del pianeta. Il messaggio forse più importante è stato probabilmente che non esiste una concezione della natura neutra ed universale, ma che essa è dipendente dalla cultura e dalla storia della società di cui si fa parte. Usando le parole dell’antropologo Marshall Sahlins, «Il modo in cui l’Occidente moderno rappresenta la natura è la cosa meno condivisa nel mondo». Le comunità native del Pacifico, ad esempio, si sentono connesse con il resto della biosfera, e anche con il mondo minerale, attraverso l’aria che tutti gli organismi respirano; un senso di appartenenza, ma anche di dipendenza e in un certo senso di obbligo morale verso la Terra che è estraneo alla cultura occidentale. Anche in questa presentazione è stata posta l’enfasi sull’importanza dello storytelling per raccontare il cambiamento climatico: «possiamo trasformare le nostre conoscenze sul clima, sul suolo, sul vento e sulle correnti non in dati, ma in storie».
